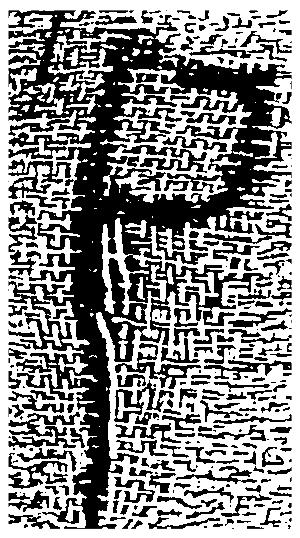Un ripasso di storia
di Pino Di Miceli
“Garibardi
fu feritu, fu feritu nto vuddicu, c’affacciau un peri ficu…”
Così cantavamo cinquant’anni fa, allorquando per le strade di
Mezzojuso intendevamo cimentarci - con innocente ironia - con canti
ed inni risorgimentali.
Dai versi viene fuori una lettura tra il mitico e l’ironico, come,
del resto, il mito da un lato (la spedizione di due anni prima già
diventata mitica e quindi, magicamente, da ripetere) e la realtà
molto più prosastica (terra terra) si rivelarono le costanti
dell’operazione garibaldina che nel 1862 fu fermata sull’Aspromonte.
Cascàmi, cascàmi di storia, e di interpretazione storica, decaduta a
livello popolare, direbbe qualcuno.
Eppure… eppure non è così e ne abbiamo parlato in un precedente
scritto. Perché lì c’è l’incontro tra la macro e la micro storia.
La mia generazione è cresciuta negli anni della scuola elementare
con la retorica risorgimentale. Era talmente pervasiva che non te ne
accorgevi. Era una retorica da libro Cuore ancor viva dopo più di
settanta anni dalla sua pubblicazione.
Già nei primissimi anni della scuola elementare ci catapultò addosso
il centenario dell’unificazione nazionale, con la distribuzione agli
alunni di un libretto celebrativo e una visita degli eredi di
Garibaldi ai luoghi che videro combattere in Sicilia l’eroe dei due
mondi, loro antenato.
La visita a Mezzojuso di uno dei discendenti di Garibaldi fu per me
traumatica, per un semplice motivo: all’uscita dall’edificio
scolastico quell’omone - alto, solenne e barbuto - salì veloce, col
suo seguito - probabilmente parenti - su una grossa automobile sul
cui lunotto posteriore giaceva una spada… una spada gialla, di
plastica: che delusione!
Fu un autentico trauma! Per me Garibaldi era quello delle
illustrazioni del sussidiario, con Andrea Rao come suo
rappresentante mezzojusaro: ma con una spada vera! Ebbene,
quell’episodio sembra la metafora di ciò che hanno vissuto le ultime
generazioni di ragazzi, studenti e giovani a proposito del
Risorgimento italiano. Ci avevano abituati alle poesie di Giusti
(Sant’Ambrogio), di Mercantini (La spigolatrice di Sapri), all’Inno
di Garibaldi, a Fratelli d’Italia, ma anche a tutto ciò che per
quella retorica poteva riferirsi all’orgoglio nazionale: Va’
pensiero, O Signore, dal tetto natìo, dei Lombardi alla Prima
Crociata. Oppure: “Suoni la tromba e intrepido io pugnerò da forte,
bello è affrontar la morte, gridando libertà” (dai Puritani di
Bellini) ed ancora: “Quando passano per via gli animosi bersaglieri,
sento affetto e simpatia, pei gagliardi militari”, ecc.
Questi canti e quelle poesie riempivano i nostri saggi ginnici di
fine anno scolastico o di fine mese (alle colonie estive) davanti
alle autorità religiose, civili e militari. Assieme alle scultoree
frasi: O Roma o morte, Obbedisco, Tirremm innanz, Fatta l’Italia,
bisogna fare gli italiani, Viva Verdi!, ecc. Insomma, buona parte
della retorica fascista – mutatis mutandis - era ancora tutta l..
Bei tempi, dice ancora qualcuno e non riesci a distinguere se per
nostalgia o per nostalgie. Mancava un aspetto in tutto
quell’orizzonte: la storia locale o, meglio, l’intrecciarsi tra la
micro e la macro storia nelle nostre contrade nel periodo
risorgimentale. Ed è proprio questa la cifra dei decenni che videro
la nostra comunità mezzojusara impegnata in maniera diretta e
costante nel movimento risorgimentale. Ne ha scritto in maniera
dignitosissima il nostro caro Ignazio Gattuso nell’opera Spigolature
Risorgimentali, un libro che nessuno sfoglia anche se ristampato,
assieme alle altre opere, appena pochi anni fa. Ed il Gattuso ci
farà compagnia in questo breve scritto.
La nostra storia inizia non in paese, ma in campagna, in una delle
contrade dove alcuni concittadini, avendo costituito una vendita
carbonara, si incontrano e da dove partono “missionari” della causa:
uno è fermato a Villalba dalla polizia borbonica: gli trovano un
catechismo della carboneria. E così si viene a sapere che anche il
principe di Mezzojuso, l’ultimo dei Corvino, Francesco Paolo, ne fa
parte. Siamo nella prima metà degli anni venti del XIX secolo.
Controllati dalla polizia, escono allo scoperto nel 1848. Si
preparano le squadre, pronte ad intervenire al primo allarme in
città. Si dà il proprio apporto fattivo nella “rivoluzione”
siciliana e in quella che si continua a chiamare la Prima Guerra
d’Indipendenza: diversi mezzojusari infatti partono volontari per il
nord. Tra i tanti che si distingueranno a Palermo ricordiamo Dario
Battaglia, medico notissimo in città (curerà anche la zarina di
Russia). Ma l’episodio più eclatante, anche come eco che sbarcherà
in continente, è quello legato alla vicenda di Francesco Bentivegna.
Me preme, en passant, ricordare che uno dei luoghi di cospirazione
anti borbonica fu per gli arbresh di Sicilia il seminario di
Palermo. Idee e sentimenti libertari erano poi comuni ai giovani
intellettuali calabro-albanesi, fin dai tempi napoleonici.
Ebbene,sulle vicende di Bentivegna è presente questo miscuglio di
ascendenze culturali: sicilianissimi protagonisti, misti a focosi
parenti di papàs. La vicenda di Bentivegna dimostra come la
definizione di Risorgimento - come lotta di popolo o di pochi
intellettuali - sia ancora da riaprire. E’ di pochi anni fa la
commemorazione della fucilazione del Bentivegna nella piazza di
Mezzojuso. Dopo una partenza in sordina, si arriv. a una sinergia
con il comitato di Corleone con uno scambio di iniziative culturali
(presentazione di libri, mostra di pittura, spettacolo musicale sul
Risorgimento). Un episodio di cui si parla poco è quello legato al
convento della Gancia a Palermo. Il 4 aprile del 1860 al suono della
campana del convento scoppia una rivolta guidata da Francesco Riso.
Il moto è subito represso con una ventina di morti. Altri tredici
verranno in seguito fucilati. Tra essi il mezzojusaro Michelangelo
Barone. Questo episodio a quanto sembra farà rompere gli ultimi
indugi a Garibaldi per la sua impresa in Sicilia. Sull’attiva
partecipazione dei mezzojusari all’impresa dei Mille l’opera del
Gattuso a questo punto è abbastanza meticolosa nella narrazione dei
fatti e nell’individuazione dei protagonisti. Non tacerei, per in
questo pur semplice articolo, del proclama di La Masa ai
mezzojusari, segno che anche i nostri più diretti antenati, nei
riguardi dell’impresa garibaldina, nutrivano speranze che andavano
ben al di là di un semplice cambiamento di governo. Queste stesse
speranze saranno espresse da l. a due anni alla Ficuzza, quando
all’inizio dell’agosto del 1862 si alternarono le grida di “O Roma o
morte!” da un lato e di “Pane, pane” dall’altro. Il Gattuso continua
poi con la venuta di Garibaldi a Mezzojuso, con un accenno al
brigantaggio dalle nostre parti e con il contributo mezzojusaro alla
rivolta del Sette e Mezzo del 1866. Sarebbe proprio da rileggere
tutta questa storia. Senza enfasi, anche perché in tono molto pacato
l’ha scritto il Gattuso. Un modo non retorico di celebrare i primi
centocinquanta anni del nostro Stato. Un ripasso di storia, che non
è solo locale. Un altro ripasso ben più approfondito sarebbe poi da
fare su cosa abbiamo messo e/o hanno messo nella nostra valigia una
volta intrapreso il viaggio postunitario. Cosa è stata Mezzojuso
dopo l’unificazione nazionale? Quale apporto volontario, forzato,
consapevole o distratto abbiamo dato allo sviluppo della comunità
nazionale? E quale contributo ha dato la comunità nazionale al
nostro sviluppo? Qui il Gattuso non può aiutarci più. Dobbiamo
chiamare in causa la nostra onestà intellettuale e soprattutto
umana. Il discorso si complica. Abbiamo offerto braccia e vite per
fabbriche e guerre. Siamo stati punti di riferimento per i comuni
vicini per poi crollare improvvisamente. Abbiamo prodotto
generazioni di intellettuali che si sono affermati anche in campo
nazionale e nello stesso tempo la fame, la malattia, la
superstizione ci abbrutivano. Abbiamo litigato tra greci e latini
per qualche processione ma adesso sappiamo coltivare la memoria
culturale come pochi. Siamo stati ubbidienti e supini di fronte al
potere ma qualche scatto d’orgoglio ha caratterizzato i nostri tempi
migliori. E via di seguito. Sono degli esempi personalissimi, delle
rappresentazioni non esaustive. Ognuno può espungere, aggiungere,
modificare. Ma abbiamo un’emergenza: le nuove generazioni. E’ ancora
possibile offrire tutto questo o dobbiamo cercare, assieme, altre
vie? Sbrighiamoci perché “a cira squagghia, ma a pricissioni un
camina!”